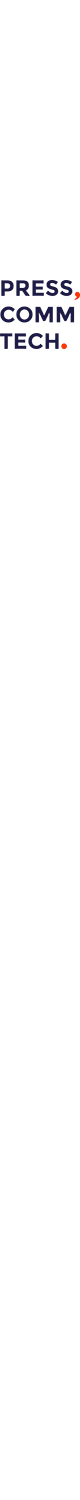di Alessandro Paesano #Milano twitter@gaiaitaliacomlo #MixFestival
di Alessandro Paesano #Milano twitter@gaiaitaliacomlo #MixFestival
Con il secondo giorno di proiezioni il Festival Mix di Milano, 32ma edizione, è entrato nel vivo della sua ricca programmazione. Delle tre sezioni del Festival, lungometraggi, cortometraggi, documentari, con relativi premi e giurie, ieri siamo riusciti a vedere tre lungometraggi di caratura diversa e due documentari completamente diversi l’uno dall’altro, com’è giusto che sia in un festival che vuole garantire massima rappresentatività ai generi e ai formati cinematografici scelti.
Dykes, Camera, Action (t.l. Lesbiche, cinepresa, azione) (Usa, 2018) di Caroline Berler, è un documentario nella sua forma più classica, che, attraverso interviste e brani di tantissimi film, ricostruisce l’atmosfera pionieristica che caratterizza il panorama cinematografico degli Stati Uniti d’America negli anni 70, quando una nuova generazione di registe e attiviste, donne, femministe e lesbiche, producono una serie importante di film, diversissimi tra di loro incentrati nei rapporti tra donne, tra emancipazione e amore anche (omo)sessuale.
Berler intervista Barbara Hammer, Su Friedrich, Rose Troche, Cheryl Dunye, Yoruba Richen, Desiree Akhavan, Vicky Du, mentre critiche cinematografiche come B. Ruby Rich e Jenni Olson ricostruiscono le pratiche della visione cinematografica (come si andava al cinema e perché) e analizzano la presenza dei personaggi lesbici nel cinema di allora.
Se nel cinema mainstream le lesbiche venivano descritte in termini assolutamente negativi, presentando prospettive di solitudine e sofferenza come nel caso del terribile The Killing of Sister George (t.l. L’assassinio di Sorella George) (Usa, 1968) di Robert Aldrich, o dove i personaggi lesbici si suicidano perché non accettano la propria condizione, come in The Children’s Hour (che in italiano diventa Quelle due) (Usa, 1961) di William Wyler, l’avanguardia cinematografica risponde con una serie di titoli, tra i quali ricordiamo Dyketactis (Usa, 1974) di Barbara Hammer e
The Watermellon Woman un mockumentary su una donna nera e lesbica, che restituiscono una presenza di donne lesbiche nel cinema, rivoluzionaria e positiva.
Dykes, Camera, Action è un documentario importante non solamente per la funzione di memoria storica che compie con precisione e interesse, né solamente per l’analisi sui generi, gli stili o la riflessione critica sulle storie lesbiche raccontate nel cinema del ventennio 70-90, comprese le ispirazioni storiche di film precedenti come i magnifici Meshes of the Afternoon (Usa, 1943) di Maya Deren, e Je Tu Il Elle (Belgio, 1974) di Chantal Ackerman. Il film di Berler è importante anche e soprattutto perché restituisce il vissuto (non solamente cinematografico) delle registe e critiche intervistate.
Ci ha sorpreso così ascoltare la regista Rosa Troche, impostasi all’inizio degli anni 90 per il suo film d’esordio Go Fish (Usa, 1994) film indipendente approdato alla distribuzione mainstream, giunto anche in italia (miracolosamente col titolo originale) dichiarare, scherzando, di appartenere alla categoria delle lesbiche vecchie avendo solamente 54 anni.
E’ evidente che anche Troche è vittima della dittatura della gioventù dei modelli omosessuali maschili e anglofoni (statunitensi e britannici) che soffre di un evidente ageismo.
Per fortuna il documentario ci mostra la bellezza di tante altre donne davvero old e ancora magnificamente sulla piazza. Interessante il vissuto di Sarah Schulman che, raccontando delle sue emozioni alla visione di Quelle due commenta dicendo che non le diede fastidio il fatto che, alla fine del film, la protagonista appena dichiaratasi lesbica si suicida impiccandosi e che la scena di dichiarazione per lei era positiva, concludendo che, in una società dove scarseggiano i film con personaggi lesbici positivi ti accontenti anche delle briciole.
E qui ci fermiamo per lasciare spazio agli altri film che abbiamo visto, augurandoci che Dykes, Camera, Action possa trovare una distribuzione anche in Italia e che venga studiato nelle università, fonte preziosa di informazioni, di pareri, di storia, e di film.

Mr. Gay Syria (Turchia, Germania, Malta, Francia, 2017) di Ayse Toprak appartiene ai documentari di finzione nei quali, cioè, nonostante il materiale narrativo del film sia “reale” e è accaduto nonostante la realizzazione del film la storia viene raccontata secondo gli stilemi del film di finzione.
Il film si apre con il protagonista, Husain, siriano rifugiato in Turchia, che si lamenta al telefono con la madre che tutto è andato male. In flashback, sei mesi prima, il film ci racconta della sua decisione di partecipare al concorso come Mr. Gay Siria, il vincitore parteciperà al concorso internazionale Mr. Gay a Malta, nella speranza che possa sensibilizzare l’opinione internazionale sui diritti traditi delle persone siriane omosessuali.
Husain partecipa al concorso mettendosi in mostra nonostante la sua famiglia non sappia della sua omosessualità anche se poi non riesce ad ottenere il visto per Malta e la sua famiglia, scoperta o il suo orientamento sessuale lo ripudia.
Il documentario è interessante nei contenuti, a saperli vedere in tralice, al di là della vocazione narrativa del suo regista.
E’ interessante misurare il grado di relativa libertà che le persone omosessuali hanno in Turchia – che non evita loro le cariche della polizia per un Pride a Istambul non autorizzato (tra le riprese più belle del documentario) – che è nulla rispetto quella che abbiamo in Europa, anche in paesi omonegativi come l’Italia, ma che rispetto la Siria, dove le persone omosessuali rischiano almeno 3 anni i reclusione per rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso anche tra adulti consenzienti, diventano vivibili e agevoli.
Hussein e Mahmoud, l’organizzatore del concorso Mr. Gay Syria, vivono sulla propria pelle la superficialità dell’accoglienza e assistenza delle associazioni lgbt occidentali che non sanno nemmeno capire il tipo di problemi che questi due giovani uomini siriani hanno nei confronti della loro cultura natale e del proprio orientamento sessuale.
Altrettanto interessante è notare la colonizzazione culturale statunitense che caratterizza il vissuto omosessuale di Mahmoud e di tutti i partecipanti al concorso che aderiscono a uno stile di vita occidentale che non corrisponde a quello che vivono quotidianamente nel proprio contesto di giovani migranti ed esuli, schematizzando in chiave “gay” la vita cui vorrebbero poter accedere che è di più ampio respiro.
Dispiace che il documentario, che ha la vocazione del film narrativo e arriva a 90 minuti di durata quando poteva benissimo restare tra i 60 e i 70 minuti, si soffermi su dettagli folcloristici della preparazione del concorso di Mr. Gay Syria ma nulla ci dica della vita di Hussein, che scopriamo sposato e padre di una bambina, famiglia della quale nulla ci è dato sapere.
Così come nessun accenno viene fatto alla religione il documentario ignorando le abitudini dei ragazzi ripesi senza degnarci nemmeno di dire se tutti i ragazzi ritratti sono secolarizzati o praticano (né quale sia il motivo di questo silenzio assordante). Quelli presentati dal documentario sono persone infatti e non personaggi e il criterio con cui si mostrano o meno parti delle loro vite non è una scrittura più o meno esauriente ma una descrizione che si fa censoria.
Questa ambiguità di fondo mina l’efficacia politica e anche etica del documentario; alla fine, ci chiediamo perché Ayse Toprak invece di filmare la disperazione di Husein quando Malta gli rifiuta il visto e non può dunque partecipare a Mr. Gay non si sia prodigato ad aiutarlo in maniera più concreta. E’ sempre il limite di questo approccio documentaristico che corre sempre il rischio di spettacolarizzazione le disgrazie altrui il confine tra spettacolarizzazione e denuncia essendo sempre ambiguo e immerso in una zona grigia. E alla fine la sensazione che noi occidentali viviamo queste narrazioni come storie pittoresche dalle quale smarcarci perché noi siamo meglio di quegli stati e quelle società non ci lascia nemmeno usciti dalla sala a vedere il film successivo.
Tinta Bruta (t.l. Inchiostro grezzo) (Brasile, 2018) di Felipe Matzembacher e Marcio Reolon racconta del giovanissimo Pedro, che, espulso dall’università per una rissa per la quale è sotto processo, si esibisce in webcam spogliandosi e dipingendosi con vernice fluorescente.
Il film, dall’andatura lenta e discreta, ci mostra una serie di abbandoni e violenze che Pedro subisce, alle quali risponde con una timidezza e un candore indescrivibili (magistralmente restituiti da Bruno Fernandes che lo interpreta on grande generosità).
Pedro rimane da solo quando la sorella lascia Porto Alegre (una città costruita su un terrapieno che sta lentamente sprofondando) per andare a lavorare a Salvador dall’altra parte del Paese.
L’incontro con Leo (Shico Menegat) che gli ha rubato l’idea dei colori fluorescenti e ha più visualizzazione di lui, gli permette di entrare in contatto con le sue emozioni (Leo gli confessa di conoscerlo da quando è stato arrestato per la rissa, che, scopriamo, essere stata la reazione ad anni di bullismo omofobico sin dai tempi del liceo…).
I due ragazzi fanno degli show insieme nei quali si amano. Ma Pedro viene abbandonato anche da Leo che si reca a Berlino dove è entrato in una compagnia di danza (fa il ballerino) e Pedro rimane da solo anche in vista del processo col quale rischia gli arresti domiciliari.
Pedro subisce tutto in silenzio mostrando solo qualche scatto di stizza, in privato, come un bambino che fa i capricci, dimenandosi sul letto in preda all’ira, resistendo a due aggressioni quella di due compagni di università, scampata grazie all’intervento di Leo e quella di un ragazzo rimorchiato in un bar che poi gli estorce denaro pretendendo di essere un’escort.
 Molto belle le scene in solitaria e in coppia di Pedro e Leo a favore della webcam che mostrano senza pudore quanto può succedere in questi show (anche “in soggettiva” dal punto di vista della webcam) e cosa accade nella vita privata del ragazzo compresi alcuni amplessi con Leo (solo uno dei quai ridondante e inutilmente reiterato) compreso l’amplesso con un ragazzo che lo ha rimorchiato una sera che Pedro si sente più solo del solito (tanto da aver accettato di incontrare uno dei sui fan in webcam che però si limita a osservarlo in incognito e da lontano) ragazzo del quale il film ci mostra il membro consistente e la faccia assente di Pedro che, da ricettivo, non sente niente.
Molto belle le scene in solitaria e in coppia di Pedro e Leo a favore della webcam che mostrano senza pudore quanto può succedere in questi show (anche “in soggettiva” dal punto di vista della webcam) e cosa accade nella vita privata del ragazzo compresi alcuni amplessi con Leo (solo uno dei quai ridondante e inutilmente reiterato) compreso l’amplesso con un ragazzo che lo ha rimorchiato una sera che Pedro si sente più solo del solito (tanto da aver accettato di incontrare uno dei sui fan in webcam che però si limita a osservarlo in incognito e da lontano) ragazzo del quale il film ci mostra il membro consistente e la faccia assente di Pedro che, da ricettivo, non sente niente.
Però quando Leo lo abbandona in malo modo, andandosene senza salutarlo, e a Pedro non rimane che salutarlo non visto con un cenno della mano mentre lo vede allontanasi in macchina, Pedro invece di incassare il colpo impassibilmente reagisce in maniera vitale e gioiosa e si mette a danzare.
Un film dal perfetto equilibrio dove le scene di nudo e di sesso sono sempre necessarie e importanti per la storia e dove le vicissitudini di questo ragazzo solo e abbandonato non scaturiscono dalla sua omosessualità ma rappresentano il percorso di una persona che tra le altre cose è anche omosessuale.
Girato con una splendida fotografia e una macchina da presa nervosa, vorace ma sempre rispettosa dei protagonisti del film Tinta Bruta è una delle perle di quota 32ma edizione del Festival Mix.
Gewoon Vrienden (t.l. Solo amici) (Paesi Bassi, 2018) di Elen Smit, presentato dal festival con il titolo internazionale di Just Friend e non con quello originale, è un tv movie commissionato dalla tv olandese insieme ad altri tre per parlare dell’amore. In questo film l’amore è quello tra due giovani ragazzi entrambi senza idea alcuna sul proprio avvenire, uno, Yad, di origini siriane, appena rientrato da Amsterdam, dove non è riuscito a combinare nulla, l’altro, Joris, viziatissimo dai soldi che la madre ha ottenuto dal risarcimento dell’assicurazione dopo la mote improvvisa del padre. Entrambi vivono in una provincia meno asfissiante di tante altre ma che non dà loro comunque alcuna prospettiva di emancipazione.
Il film, pur rimanendo sui toni leggeri della commedia, riesce a trattare in maniera intelligente e senza cliché la storia d’amore tra i due ragazzi (tradizionalmente molto belli, soprattutto il mozzafiato Josef Stradowki) ma anche la storia familiare di entrambi.
Quella di Joris, al quale manca molto il padre, morto quando lui aveva poco più di 11 anni, e quella di Yad i cui fidanzati del passato non hanno trovato approvazione materna.
La figura materna è anche quella della nonna di Joris, la madre di sua madre, una allegra 80enne molto più piena di vita della figlia, quest’ultima incattivita dai tradimenti del marito e che cerca di rimanere giovane con continui interventi chirurgici.
Un film che mostra come nonostante le resistenze e le chiusure dei personaggi basti davvero poco per aprirsi all’amore e al cambiamento, unica regola di crescita e felicità.
Un film leggero ma non superficiale, divertentissimo senza scadere nelle battute trite, che contribuisce a un immaginario collettivo dove l’omosessualità (maschile) trova uno spazio positivo, riconosciuto e di pari dignità.
Un piccolo passo per la tv olandese un passo da gigante per quella italiana.
Non convince nemmeno un po’ invece il patinato ma vuoto Postcards from London (Regno Unito, 2018) di Steve McLean che trona dietro la mdp dopo il suo Postcards from America del 1994.
McLean, che firma anche la sceneggiatura, racconta di Jim che arriva a Londra dalla provincia in cerca di avventura e diventa un escort di alta classe specializzato in conversazioni colte post-coito (letterale nel film).
Il film è girato con una fotografia che omaggia quella di Pierre & Gill e certo cinema di Derek Jarman (con qualche reminiscenza del Van Sant di My Own Private Idaho) e, ça va sans dire David LaChapelle.
A differenza delle fonti che omaggia che mostrano la nudità e l’atto sessuale compresi liquidi biologici (urina, sperma) (Pierre & Gil) e le differenze di classe (LaChapelle) le immagini in McLean rimangono fine a se stesse e cieche all’estrazione sociale e alla realtà concreta ed organica della prostituzione maschile (sangue sperma sudore e merda) senza almeno uno dei quali la prostituzione è trasfigurata in qualcosa di asettico e irreale, facendone una posticcia affinità elettiva tra ragazzoni che citano a memoria date e circostanze della vita e delle opere di Caravaggio o di Bacon o di Lucien Freud.
Il film ha come protagonista il bellissimo e altrettanto bravo Harris Dickinson il protagonista di Beach Rats (Usa, 2017) di Eliza Hittman che in quel film si era generosamente mostrato in un nudo frontale e che qui non mostra nemmeno un centimetro di pelle.
Non ci fraintenda chi legge. Non bramiamo la nudità di per sé, ma ci dà fastidio se si parla di un argomento che ha al suo centro la nudità senza che il dettaglio scomodo venga mai mostrato attestandosi a un pudore borghese oggi superato e stantio. Belli ma non eccezionali i tableau vivent sui quadri di Caravaggio, quando Jim, affetto da sindrome di Stendhal, sviene di fronte quei capolavori e si immagina di vivere dentro il quadro come modello al cospetto di Caravaggio che violento e irascibile compare in queste sequenze e sfida Jim a duello quando questi lo chiama frocio (in italiano nel film).
Una bella idea per un mediometraggio ma un po’ poco per un lungometraggio che ha poco da dire e reitera le stesse scene e situazioni senza variante alcuna.
E gli 87 minuti di durata sembrano 200…
(23 giugno 2018)
©gaiaitalia.com 2018 – diritti riservati, riproduzione vietata